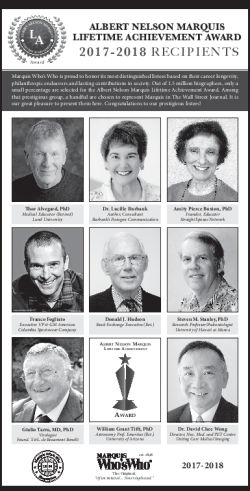Quando incontrai Venerina era il 1972; lo ricordo come se fossi oggi.
Quando incontrai Venerina era il 1972; lo ricordo come se fossi oggi.
Era una gelida domenica di gennaio e tornavo dall’Olanda dove avevo partecipato a non so più quale simposio scientifico; stanco morto, ero appena entrato a casa che lei mi accolse con un “Miao” pieno di irritazione, come se avessi fatto tardi a prepararle la cena. Come tutti i pignoli, ho la fisima di controllare la chiusura di tutte le finestre prima di uscire e, sbalordito, stavo per domandarmi da dove diavolo fosse entrata quella gatta che quella esplose un altro “Miao”. Irritato, mi guardai intorno per decidere il da farsi. Una gatta: figuriamoci! Con tutti gli impegni e i congressi che mi occupavano fuori casa, di certo non avrei trovato neanche un minuto per… Comunque, mi ricordai, in frigorifero c’era ancora una scatoletta di tonno. Ma si. Una bella mangiata di tonno e poi “quella è la porta”.
Ovviamente non è andata così
Ancora oggi, mi commuovo se penso a quei tredici anni passati con Venerina. Alle innumerevoli telefonate a sbalorditi colleghi e amici per piazzare la nidiata di gattini che mi aveva scodellato in casa; al suo precipitarsi nella mia valigia aperta o davanti la porta per impedirmi di recarmi fuori Napoli; ai convegni saltati per starle vicina (specie quando, a quattro anni, si ammalò di tumore alla mammella), alla sua gelosia e ai graffi contro le ragazze che ogni tanto portavo nel mio appartamento…
Allora non facevo parte del movimento antivivisezionista e, come praticamente tutti i miei colleghi, ritenevo del tutto ovvio sacrificare animali alla ricerca medica: montagne di cavie, topi, conigli, cani, gatti. E se qualche ricercatore fosse stato attraversato da dubbi o, addirittura, scrupoli poteva sempre rifugiarsi nella Verità decretata dalla Scienza Ufficiale che bollava allora come eresia qualsiasi tentativo di eliminare o ridurre il sacrificio degli animali nella ricerca scientifica.
Intanto la mia luna di miele con Venerina andava avanti. È difficile spiegare cosa si verificò in me ma credo possa capirlo chiunque abbia avuto un gatto in casa. Quel suo sguardo, quei suoi occhi che continuavano a fissarmi, addirittura per ore, quando decideva che era arrivato il suo momento di saltarmi sulle ginocchia, o sul petto quando stavo sdraiato, cominciavano a comunicarmi qualcosa che mai avrei potuto conoscere dai libri o dalle mie ricerche. Più che conoscenza era consapevolezza: qualcosa di immensamente più profondo. Era la sensazione, come trovai scritto qualche anno più tardi in un libro di Borges, che, al di là della specie che ci divideva, al di là del tempo che ci avrebbe divisi, c’era in noi due una indissolubile unità, una comunione, creata dall’essere entrambi un prodotto dell’universo: le stelle, le ceneri di queste, gli elementi, le molecole, la Vita.
Non vorrei portarla a lungo con queste che a qualcuno potrebbero apparire melensaggini ma fatto sta che un giorno in laboratorio mi ritrovai per due ore, sotto gli occhi sbalorditi dei miei colleghi, a cercare di rianimare un furetto. Quella cavia di laboratorio stava morendo per un attacco cardiaco provocato dalla insolita reazione a non so più quale sostanza che gli avevamo iniettato. Una “interessante” reazione che, forse, secondo i dettami dell’allora imperante Medicina, avremmo dovuto limitarci a trascrivere su qualche protocollo di laboratorio o, ancora meglio, su un articolo da pubblicare su qualche rivista scientifica per garantirci così un altro passettino verso una luminosa carriera accademica.
Così non fu. E dopo due ore di tentativi, glissai i miei colleghi che, guardandomi con commiserazione, non osavano domandarmi perché mai avevo speso due ore della mia attività di ricercatore per salvare un furetto destinato, al pari dei suoi simili nello stabulario, a morire in ogni caso. Mi inventai un malessere (mi pare, un dolore alla schiena) e mi presi un giorno di permesso. Me ne stetti a casa ad accarezzare Venerina.
Di certo non volevo abbandonare la ricerca scientifica, ma c’era un modo per renderla la meno traumatizzante possibile per gli animali? Allora non c’era Internet e, pertanto, cercavo nelle librerie e nelle biblioteche per trovare un qualche testo che rispondesse alla domanda. Quando mi imbattei in un testo che parlava del “Caso Talidomide”
Nel dicembre 1961 tutti i farmaci composti da Talidomide (una molecola inventata dalla ditta tedesca Chemie Grünenthal) furono ritirati dal mercato. Fino ad allora questo sedativo anti-nausea era stato un farmaco leader, venduto (sopratutto alle donne gravide in 50 paesi sotto quaranta nomi commerciali diversi. Poco alla volta, la verità era venuta fuori: il Talidomide poteva provocare nei feti gravissime malformazioni quali amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti), generalmente a carico degli arti superiori. La tragedia del Talidomide che aveva marchiato per sempre, nei soli paesi occidentali, almeno 10.000 bambini si trasformò, anche per i risarcimenti stratosferici in gioco, in un colossale caso giudiziario. Il processo, cominciato nel dicembre 1967, verteva sul rispetto delle procedure previste per la sperimentazione finalizzate alla produzione di farmaci. Tutte rispettate ribadì la Chemie Grünenthal e la sua consociata Distillers Company, trincerandosi dietro le innumerevoli sperimentazioni animali che aveva effettuato prima di immettere in commercio il Talidomide, attestanti la mancanza di seri effetti collaterali, anche quando la molecola era stata testata su cavie gravide.
Iniziarono così ad apparire nel mondo accademico i primi timidi dubbi sulla validità della sperimentazione animale. E fu proprio di quei giorni che lessi una dichiarazione di uno scienziato che, qualche anno più tardi, avrebbe cambiato la mia vita, Albert Sabin, l’inventore del vaccino contro la poliomielite: “L’invenzione del vaccino contro la poliomielite è stata a lungo ritardata per via della concezione errata della natura della malattia nell’uomo, che era basata su modelli sperimentali fuorvianti della malattia stessa nelle scimmie. I primi vaccini contro la rabbia e la polio funzionarono bene sugli animali ma storpiarono o uccisero i pazienti a cui furono somministrati.” E poi, aggiungeva: “Perché sono contro la vivisezione? Il motivo principale è che si tratta di cattiva scienza che produce parecchi dati fuorvianti e disorientanti, pericolosi per la salute umana. E’ anche uno spreco del denaro dei contribuenti prendere animali sani e causare loro – artificialmente o con la violenza – malattie che normalmente non svilupperebbero o che svilupperebbero in forma diversa, quando disponiamo già di persone malate che possono essere studiate in fase di cura”.
Ce n’era abbastanza per dare un nuovo corso al mio lavoro di ricercatore. Anche perché cominciavo a rendermi conto che buona parte delle cosiddette pubblicazioni scientifiche, basate sul sacrificio degli animali, erano assolutamente inutili riproponendo, per lo più, esperimenti fatti e rifatti già centinaia di volte. Esperimenti finalizzati esclusivamente per una qualche pubblicazione, per rimpinguare un qualche curriculum. Comunque, per me, queste che sono oggi diventate strutturate convinzioni erano, allora, un mero stato d’animo, un impalpabile malessere nel vedere innumerevoli cavie soffrire e morire.
Cercavo di condividere le mie perplessità con qualche collega ma finivo per fare il vuoto intorno a me; parlare di diritti degli animali in un laboratorio di ricerca sembrava, allora, più che un’eresia, un’assurdità. Oggi l’attenzione per i diritti degli animali si sta conquistando uno spazio sempre più grande tra i mass media e può sembrare “normale”, quasi un vezzo, che ci si batta contro la vivisezione; ma posso assicurare che allora, negli anni “80, per un ricercatore impegnarsi con temerarietà in questo campo significava bisticciare con i colleghi, perdere finanziamenti, dire addio a progetti di ricerca. Per fortuna sono testardo. E poi mi piace discutere, convincere la gente. Cominciai a scrivere articoli per associazioni animaliste (tra le quali la Limav – Lega Internazionale Medici per l’abolizione della Vivisezione, della quale mi onoro di essere Presidente) e a tenere conferenze. Tutte corredate dall’immancabile domanda: <<Ma, Professore… É meglio che muoia una scimmia o un bambino?>>
Non mi sono mai piaciute le risposte nette; anzi, per fare mie le parole di Carl Gustav Jung, “Ciò che è senza ambiguità e senza contraddizioni coglie soltanto un lato delle cose”. Per questo non mi sono mai piaciuti gli “schieramenti”: inconciliabili fronti che da posizioni opposte trasformano il dibattito in una rissa o una battaglia. Ancora di più quando si parla di utilizzo degli animali nei laboratori di ricerca: un argomento che, di certo, non si può affrontare con gli anatemi. E ne ho visti, e affrontati, tanti di “guerrieri”, “pro” o “contro” la vivisezione, tutti bardati di irremovibili certezze, nelle innumerevoli conferenze che ho tenuto in questi decenni. Ancora peggio quando c’è una televisione che, per esigenze di audience, ha bisogno di trasformare un dibattito scientifico in una rissa da pollaio.
Ma accantoniamo momentaneamente la questione e parliamo di Vivisezione. Anzi, no: riparlo ancora di Venerina, e di quella sensazione di benessere che era capace di irradiare. Un dono che, come medico, ma sopratutto come curioso, mi ha sempre intrigato. “Un miao massaggia il cuore” sentenziava Boris Levinson, lo psichiatra, considerato ideatore della moderna Pet therapy, che cercò di capire l’origine degli effetti terapeutici della compagnia degli animali; un enigma che, pur restando un medico “ortodosso” anche io, ho cercato, se non di svelare, almeno di comprendere.
Intanto, come potrebbe l’animale “trasmettere” i suoi innegabili effetti benefici e, quindi, curativi? Si è ipotizzato di tutto: ormoni, onde elettrico-cerebrali, microparticelle annidate nel pelo… Ma tutte le ipotesi si sono rivelate vane. Ci si è rassegnati, quindi, ad ipotizzare che la vista, la mera vicinanza, di un animale da compagnia stimoli il nostro cervello inducendo la riduzione di sostanze quali adrenalina ed i glucocorticoidi portano la persona ad uno stato di rilassamento e quindi di benessere. Ma questa “spiegazione” di ordine psicosomatico, sebbene comunemente accettata dall’opinione pubblica, e dallo stesso mondo medico, nonostante gli innumerevoli studi condotti non ha mai trovato un solo elemento che stabilisse come fa la “mente” ad influenzare la “materia” e cioè il “corpo”; tornerò su questa questione quando parlerò del mio approccio, come medico, con i miracoli. Intanto (e mi si scusi se ho troppo divagato) torniamo alla questione vivisezione.
La vivisezione animale come fondamento della ricerca medica umana si è diffusa, sostanzialmente, per “merito” di un medico francese Claude Bernard (1813-78). Sulla sostanziale fallacia dei suoi crudeli esperimenti non credo valga la pena qui di soffermarsi; basti ricordare che due suoi assistenti, George Hoggan e Arthur de Noë Walker, lasciarono inorriditi il suo laboratorio, e fondarono la prima associazione contro la vivisezione. Mi piace, invece, soffermarmi su una dichiarazione di Bernard “Uno degli ostacoli maggiori che l’uomo incontra lungo il cammino della conoscenza è rappresentato dalla tendenza delle acquisizioni umane a trasformarsi in sistemi.” Un’affermazione certamente roboante e che suscita innumerevoli letture ma che nel contesto nel quale fu pronunciata (il tentativo di Bernard di difendersi dalle accuse di inutili crudeltà sugli animali) affida alla Scienza (con la “S” maiuscola), il compito di sbaragliare consolidate strutture culturali: una concezione questa alla base del positivismo scientifico e che ha finito per trasformare oggi lo scienziato in una sorta di sacerdote laico, arrogante, sprezzante che lancia anatemi contro il “moderno oscurantismo” rappresentato, quest’ultimo, dalle organizzazioni animaliste “colpevoli” di mobilitarsi contro la vivisezione e la creazione di animali transgenici da avviare ai laboratori.
Sono stato anche io vittima di questo ostracismo, della boria di tanti miei colleghi, qualche anno fa quando, a fianco di uno sparuto drappello di “animalisti”, mi impegnai contro una sciagurata iniziativa della Comunità Europea: il Progetto REACH. La finalità di REACH (Registration, Evaluation and Authorisation) era certamente condivisibile: testare la eventuale tossicità di sostanze chimiche immesse sul mercato prima del 1981, non esistendo, prima di quella data obbligo legale per i produttori di testare i prodotti chimici per classificarli ed etichettarli. Le (poche) proteste del mondo scientifico nascevano dalla pretesa di valutare l’eventuale tossicità di queste sostanze basandosi non già su indagini epidemiologiche o su altri metodi di indagine sui quali mi soffermerò in seguito ma semplicemente (e crudelmente) utilizzando animali da laboratorio. Quanti animali? Un rapporto del Dipartimento per l’Ambiente del Regno Unito calcolava che per testare gli effetti (tossicità acuta; irritazione della pelle; irritazione oculare; sensitività della pelle; tossicità ripetuta per 28 giorni; tossicità subcronica per 90 giorni); tossicità cronica per 12 mesi; mutagenicità; tossicità nello sviluppo; tossicità nella riproduzione su 2 generazioni; carcinogenicità; tossicocinetica; ecotossicità) dei 30.000 prodotti chimici contemplati dal progetto REACH sarebbero serviti da 13 a 50 milioni di animali: una montagna di topolini, conigli, cani, gatti… che avrebbero dovuto inalare sostanze tossiche, o vedersele iniettate nelle vene, o pompate nello stomaco, o spalmate sulla pelle nuda, o spruzzate negli occhi… E il tutto con la benedizione della Scienza.
Indignato per l’assurdità del progetto cercai di coinvolgere, primi tra tutti, i miei colleghi. Devo dire la verità: mi sarei aspettato di peggio. Certo, il gruppo di ricercatori che riuscii ad aggregare contro il REACH non poteva certo dirsi numeroso ma, per fortuna i dinieghi dei miei colleghi motivati con trite argomentazioni quali “tanto noi non abbiamo nessuna remora a mangiarci una bistecca” o i “supremi interessi della Scienza” furono molto meno di quanto mi sarei aspettato. Tornerò più avanti su questo sotterraneo ma sostanziale cambiamento che ha conosciuto negli ultimi anni il mondo scientifico italiano nei riguardi dei temi etici; va detto, comunque, che la principale responsabilità del persistere di una metodologia così fallace come la vivisezione non è da addebitare alla sola inerzia culturale ma alla disorganizzazione che in Italia regna sovrana nel mondo della Ricerca. Spieghiamoci meglio.
Il nostro Paese, che pure non brilla nel panorama internazionale per la ricerca medica, è, tra i paesi occidentale, il fanalino di coda nei diritti degli animali “da laboratorio”, E ciò nonostante una serie di “innovative” normative (Dec.Leg. 116/92, Legge 413/1993 Circolare Ministero della Salute 14 maggio 2001…) che dovrebbero rigidamente regolamentare la vivisezione che garantiscono, addirittura, l’obiezione di coscienza a medici, ricercatori, personale sanitario, studenti universitari… Il problema, tanto per cambiare, è che non esiste in Italia un efficace controllo che eviti agli animali inutili sofferenze e le autorizzazioni alla vivisezione, di fatto, vengono concesse automaticamente. Non resta quindi, oltre che attrezzarsi per far rispettare la legge (e le, speriamo, imminenti nuove normative ora in discussione al Parlamento che prevedono il divieto di uso animali nella didattica, nei test per la produzione di cosmetici e di anticorpi monoclonali tramite l’induzione dell’ascite…) sensibilizzare il mondo scientifico al problema.
Come? Intanto evitando la demonizzazione dell’”avversario” che ha scandito non poche conferenze alle quali sono intervenuto. In una, ricordo, davanti a foto che illustravano le sevizie alle quali era stato sottoposto uno scimpanzé da laboratorio, un mio collega non aveva trovato niente di meglio da fare che sovrapporre le foto di un bambino affetto da non so più quale malattia neurologica che, a dire del mio collega, sarebbe stata ben presto debellata grazie proprio agli esperimenti condotti sui primati da laboratorio. Il battibecco che era scaturito si era ben presto esteso agli animali da pelliccia (argomento che il mio collega credeva di rintuzzare indicando i bottoni d’osso e il cuoio delle scarpe dei suoi interlocutori), agli animali da circo (…“e il bue? Chi altri per millenni, sotto la sferza, ha trascinato l’aratro?”), all’effettiva utilità delle ricerche marcate Telethon… prima di trasformarsi in una specie di rissa.
La cosa curiosa è che oggi questo mio collega dirige un centro di ricerca che ha fatto dell’utilizzo di metodologie alternative alla vivisezione una bandiera. Miracolo? Onestà intellettuale? Forse si. O forse questione di marketing. Oggi occuparsi della salvaguardia degli animali, del loro benessere, ha una ottima ricaduta in termini di immagine e, quindi, di business; e i soldi sono oggi la questione fondamentale per chi fa ricerca. Forse è anche per questo che le metodologie alternative alla sperimentazione animale stanno diventando popolari, con buona pace di un “autorevole” esponente del mondo farmacologico italiano, che continua a considerarle un “anatema” e un “moderno oscurantismo”.
Il primo organico studio sui metodi alternativi alla sperimentazione animale risale al 1959 grazie a due ricercatori, Russel e Burch, e al loro metodo, comunemente definito delle 3R: Refinement (Raffinamento), Reduction (Riduzione) Replacement (Rimpiazzamento). Con Raffinamento si intende il miglioramento delle tecniche sperimentali, compiute pur sempre su animali, in modo da ridurre la loro sofferenza; in alcuni casi, si cerca, ad esempio, di usare animali filogeneticamente meno evoluti; con Riduzione si intende la riduzione del numero di animali usati, o l’aumento di informazioni ottenute con lo stesso numero di animali (è il caso della famigerata “dose letale” che oggi viene calcolata impiegando un terzo delle cavie di laboratorio che usavano qualche anno fa); con Rimpiazzamento si intende la sostituzione dell’animale con l’utilizzo di metodi alternativi. Oggi, in Europa, questi metodi alternativi sono validati dall’ ECVAM (European Centre for Validation of Alternative Methods-Centro Europeo per la Validazione di Metodi Alternativi) di Ispra, sul Lago Maggiore. Tra i test che il Centro è riuscito a sostituire quelli, crudelissimi, sulla corrosione e sulla fototossicità cutanea delle sostanze (indispensabili per l’approvazione di cosmetici) che determinavano, ogni anno, l’accecamento di decine di migliaia di conigli e altre cavie.
Ma la diffusione di sistemi di sperimentazione alternativi a quelli condotti su animali è ostacolata in molti casi dalla pigrizia mentale, anzi – per meglio dire – dal cinismo e dall’indifferenza per le sofferenze che devono patire milioni di bestiole. Si esamini, ad esempio il caso della sperimentazione su tessuti; un settore della ricerca che finora ha portato ad una ecatombe (secondo l’associazione animalista inglese Animal Aid, in Gran Bretagna vengono uccisi ogni anno 400.000 animali solo per usare i loro tessuti nella ricerca in vitro). Una strage finora giustificata dalla scarsa disponibilità di tessuti umani da impiegare nelle ricerche. Negli ultimi tempi, per fortuna, sulla spinta di mobilitazioni condotte da associazioni ambientaliste e da, ancora pochi, coraggiosi ricercatori, si sta sempre diffondendo la ricerca su tessuti umani provenienti da cadaveri, in cui i tessuti e gli organi vengono prelevati subito dopo la morte del donatore, e da biopsie e operazioni chirurgiche in cui si chiede al paziente il consenso a usare il materiale di “scarto” (sangue, placenta, cordone ombelicale, pelle, viscere, ossa, cartilagini..) ottenuto dall’intervento per la ricerca.
Ovviamente l’attendibilità di ricerche effettuate su tessuto umano è molto più attendibile di quella compiuta utilizzando tessuti animali ma nella maggior parte dei paesi europei, mentre il sistema per la donazione di organi per i trapianti è ben organizzato, non c’è alcuna linea guida sulla distribuzione del materiale non trapiantabile a fini di ricerca (tranne che per la stessa ricerca sui trapianti). In pratica, la distribuzione di organi e tessuti per la ricerca avviene solo all’interno di uno stesso ospedale, o per conoscenza diretta tra singoli ricercatori e medici, ma non esiste una vera e propria organizzazione, tranne in Gran Bretagna, dove esiste una banca di tessuti umani per la ricerca. C’e’ inoltre l’infondata preoccupazione che questo tipo di donazione possa essere considerato “in concorrenza” con le donazioni per i trapianti, e quindi sia malvista sia dal pubblico che dalle banche di tessuti esistenti (che si occupano solo di trapianti). In realtà, questo non avviene, perché molti organi e tessuti non sono comunque utilizzabili per i trapianti, mentre sono molto utili per la ricerca. Per esempio, per un trapianto di cuore l’organo viene asportato a cuore battente, e la morte è solo cerebrale. L’organo di un paziente già morto non serve per i trapianti, ma per la ricerca sì. Inoltre, esistono molti organi e tessuti che non vengono utilizzati per i trapianti, mentre possono esserlo per la ricerca. Questo per quanto riguarda le donazioni post mortem. Per le donazioni di materiale di scarto delle operazioni, il problema non si pone, perché questo non risulta di alcuna utilità per i trapianti. La donazione di tessuti per la ricerca, quindi, non si pone in concorrenza con quella per i trapianti e le eventuali resistenze psicologiche dei pazienti e della popolazione potrebbero essere superate con una campagna di sensibilizzazione e di educazione. Cosa che, per quel che è dato sapere, in Italia non si fa.
L’esposizione delle numerose tecniche di indagine che oggi permettono di evitare sperimentazioni sugli animali potrebbe continuare a lungo ma vorrei soffermarmi su una, sviluppatasi sopratutto a seguito delle mobilitazioni contro la vivisezione, che mi sembra particolarmente intrigante: la biologia dei sistemi (o Systems Biology), una disciplina che nasce dall’uso congiunto della modellistica matematica e delle più avanzate tecnologie bio-mediche, le quali sono in grado di misurare centinaia o migliaia di variabili sperimentali e/o cliniche riferite ad uno stesso osservabile quali macromolecola, linea cellulare, paziente…
Intanto, un aforisma di Marcel Proust: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.” Perché citare questa frase? Intanto perché è bella; intrinsecamente bella. E poi in questo contesto assume una valenza del tutto particolare.
Quando ero piccolo, un ammonimento mi aprì sterminati orizzonti. Me lo disse sorridendo un amico di mio padre, un ingegnere di Messina. “Giulio, guardati dagli ingegneri. Gli ingegneri hanno le risposte perché sono fissati con le invenzioni. Tu che sei curioso, lascia perdere le risposte, concentrati sulle domande, pensa alle scoperte. Le principali conquiste dell’umanità sono state scoperte, non invenzioni. Il fuoco, la liana, i tronchi rotondi… sono sempre esistiti. Il miracolo è stato quando qualcuno ha pensato di trasformarle in torce e focolari per illuminare e cuocere, corde per legare, ruote per trasportare. Le risposte sono abbandonate sotto i nostri occhi, ma è la curiosità, l’eccentrica stravaganza, la fantasia improvvisa, a trasformarle in strumenti.” Avere nuovi occhi. Accarezzare un gatto. Intuire che la ricerca meramente basata su innumerevoli esperimenti condotti sulla sofferenza degli animali porta ad un vicolo cieco. E provare ad riutilizzare risorse fino a quel momento abbandonate o sottoutilizzate. La biologia dei sistemi è nata così. Il suo obbiettivo finale è predire il comportamento della materia vivente, la sua iterazione con sostanze chimiche e organismi; la strada per realizzarlo: comprendere il funzionamento delle membrane, delle cellule, trasformarlo in algoritmi, modelli matematici, software e ottenere un flessibile strumento di manipolazione di informazione e quindi di calcolo.
Grazie alla crescita esponenziale della potenza dei computer e alla possibilità data ai ricercatori di uscire dal chiuso dei laboratori e lavorare in rete, la biologia dei sistemi ha conosciuto negli ultimi anni una crescita semplicemente sbalorditiva. Oggi, per dirne una, si è arrivati a “costruire” un virus; non uno dei tanti “virus informatici” che infestano i nostri computer, ma un algoritmo di straordinaria complessità che, immesso in un software, e quindi in un ambiente virtuale, simula perfettamente il comportamento a determinati stimoli dell’entità biologica, composta da DNA o RNA, proteine…, conosciuta come virus.
Per uno come me che ha passato la vita a studiare i virus “dal vivo” continuo a considerare la biologia dei sistemi (allo sviluppo della, anche io nel mio piccolo, ho dato un piccolo contribuito) come una sorta di magia: la vita come mera iterazione di formule matematiche e quindi software con il quale alimentare esperimenti sempre più complessi e arditi. Certo, vi è il rischio di ridurre tutta la materia biologica ad un cieco meccanismo di causa-effetto, tutto il vivente a mera sommatoria delle sue parti. E il medico ad un tecnico capace solo di scrutare il monitor, impossibilitato a stabilire un qualsiasi rapporto umano e professionale con il suo paziente.
Ma torniamo alla vivisezione. Perché, nonostante la sua fallacia, continua ad avere un posto di riguardo nei laboratori? Un piccolo esempio. Non molto tempo fa, ad un convegno sulle infezioni in ambito marino, mi capitò di ascoltare un biologo di una ASL che relazionava sui test di salubrità sui molluschi; effettuati dalla ASL iniettando biotossine algali nell’addome di topolini (detti “Mba Mouse bioassay”). Se su tre topolini sottoposti a test almeno uno moriva, i molluschi venivano considerati non commestibili; altrimenti erano OK. In ogni caso, terminato l’esperimento, tutti e tre i topolini venivano uccisi. L’affidabilità di questo metodo è a dir poco discutibile; già nel 1980 la Germania lo ha abolito e da anni, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, da anni, suggerisce una più affidabile tecnica di indagine, (tra l’altro più economica considerando l’elevato costo raggiunto oggi dagli animali da laboratorio, le spese per lo stabulario, lo smaltimento) basata su cromatografia liquida ad alto rendimento e spettrometria di massa. Chiacchierando con il biologo della ASL durante la pausa caffé mi venne, quindi, spontaneo domandargli perché mai la sua ASL insistesse con i test con le cavie. Mi rispose con un mezzo sorrisetto: “Si è sempre fatto così”.
Di solito, sono un tipo tranquillo, addirittura bonario; ma posso garantirvi che quella volta se non avessi fatto immani sforzi per trattenermi, avrei riempito di improperi il tizio della ASL che, tra l’altro, dovette accorgersi del mio stato d’animo affrettandosi, dopo una qualche frase di circostanza, con ancora in mano la tazzina di caffè, a dileguarsi tra la folla del convegno.
Perché quella mia reazione?
Forse perché , vivisezione a parte, avevo visto nel tizio, più che pigrizia mentale, quel misto di ignoranza e indifferenza per le sorti degli altri che resta l’emblema di un certa baronia scientifica e accademica; una baronia, sempre bramosa di dominio e privilegi, che ho sempre cercato di sconfiggere. Come tenterò di descrivere più avanti.