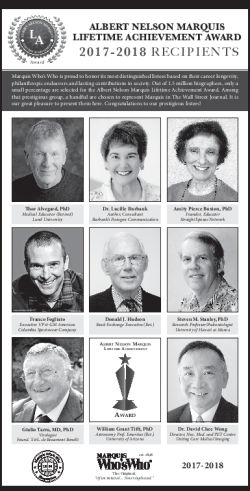Hanno suscitato solo un chiacchiericcio mediatico – ma nessuna seria considerazione medica ed etica – le dichiarazioni, nel febbraio 2014, di Danilo di Luca, stella del ciclismo e radiato dalla Federazione ciclismo dopo essere stato trovato positivo a tre controlli antidoping. Per De Luca, secondo il quale il 90% dei partecipanti al Giro d’Italia si dopa, il doping va semplicemente liberalizzato. E riferendosi all’EPO (uno dei più diffusi farmaci dopanti) così si è espresso “Innanzitutto non è una droga, non dà dei problemi, quindi non si è dipendenti. E poi, il doping fatto in maniera corretta non fa male all’organismo”.
Hanno suscitato solo un chiacchiericcio mediatico – ma nessuna seria considerazione medica ed etica – le dichiarazioni, nel febbraio 2014, di Danilo di Luca, stella del ciclismo e radiato dalla Federazione ciclismo dopo essere stato trovato positivo a tre controlli antidoping. Per De Luca, secondo il quale il 90% dei partecipanti al Giro d’Italia si dopa, il doping va semplicemente liberalizzato. E riferendosi all’EPO (uno dei più diffusi farmaci dopanti) così si è espresso “Innanzitutto non è una droga, non dà dei problemi, quindi non si è dipendenti. E poi, il doping fatto in maniera corretta non fa male all’organismo”.
Come medico e – passatemi il termine – “sportivo”, mi è difficile restare impassibile davanti a queste dichiarazioni, tranquillamente riportate sui giornali di qualche settimana fa. Intanto la somministrazione di EPO (eriproteina , un ormone prodotto naturalmente dall’organismo sano, deputato ad aumentare il numero di eritrociti e quindi il trasporto dell’ossigeno ai diversi distretti organismici e di cessione dello stesso ai tessuti impegnati nel lavoro o nella performance sportiva ) specie ai dosaggi necessari per averne significativi vantaggi in campo sportivo, provoca danni al fisico umano, alcuni dei quali possono essere anche irreversibili. Sarebbe importante sviluppare una capillare campagna di informazione sull’EPO anche perché questo ormone, per la difficoltà ad essere intercettato dai “medici dell’antidoping” e per il suo, relativo, basso costo sta diventando una droga di massa ormai comunemente usata anche nelle maratone cittadine; in eventi cioè che dovrebbero essere un mero momento di svago per gli atleti.
L’eritropoietina è, come detto, una sostanza ormonale prodotta naturalmente dall’organismo sano, che svolge il fondamentale compito di stimolare la produzione e la crescita dei globuli tossi (o eritrociti o emazie). Questa funzione di stimolazione dell’eritropoiesi viene esercitata dall’eritropoietina nel midollo osseo, sul gruppo cellulare cosiddetto dell’eritrone. L’eritropoietina agisce soltanto sulle cellule più adatte, essendo in grado di attivare una sorta di selezione che elimina le cellule meno buone, consentendo solo ad alcune di passare attraverso differenti linee di maturazione e di diventare, alla fine, eritrociti. Tale processo, in verità assai complesso, si definisce apoptosi. Questo processo è tipico dell’eritropoietina endogena, ma non di quella introdotta dall’esterno (esogena, industrialmente prodotta, allo scopo di curare alcune gravi patologie renali). L’eritropoietina ricombinante umana (rHuEPO) non è in grado, infatti, di selezionare, all’interno dell’eritrone, le cellule più adatte per diventare eritrociti: tale incapacità di discernimento (risultante nell’inibizione dell’apoptosi) comporta che tutte le cellule dell’eritrone, anche quelle imperfette, passino attraverso i previsti livelli di maturazione e diventino eritrociti. Secondo le segnalazioni provenienti dalla letteratura scientifica, ciò comporterebbe il rischio di sviluppare nel tempo addirittura malattie tumorali oltre che altre gravi patologie (eritroleucemia, policitemia vera, aplasia della serie rossa da formazione di anticorpi anti-EPO, leucemia mieloide acuta da aumentata concentrazione di EPO nel sangue, ecc).
Nonostante ciò per giorni le chiacchiere sulla somministrazione di EPO, presentato, purtroppo , come un “normale componente del processo metabolico”, hanno impestato i nostri schermi. E dato la stura a singolari richieste di “legalizzare il doping”; e questo il nome della “relatività del doping”. Secondo questo bizzarro ragionamento, – purtroppo esposto in TV anche da un medico – infatti, le sostanze che oggi non sono considerate dopanti in un futuro non molto lontano potrebbero essere considerate tali; ciò creerebbe, secondo alcuni, diversità di trattamento tra gli atleti, di oggi e di domani.
Ancora peggio quando il discorso sulla sostanziale “liceità” del doping tocca la questione dell’autoemotrasfusione: una tecnica di doping molto diffusa prima dell’avvento dell’eritropoietina (EPO) e che incrementava il numero di globuli rossi, assicurando una maggiore disponibilità di ossigeno ai muscoli, innalzando significativamente il livello prestativo dell’atleta.
Nel doping ematico autologo (autoemotrasfusione), circa un mese prima della gara dallo stesso soggetto vengono estratti in media 700-900 ml di sangue, che vengono poi conservati a +4°C e rimessi in circolo uno o due giorni prima dell’impegno agonistico. In seguito alla trasfusione si verifica un repentino miglioramento della capacità aerobica e della prestazione nelle prove di resistenza (ciclismo, maratona, nuoto di durata, trhiatlon, sci nordico ecc.), garantito da un aumento della massa eritrocitaria fino al 15-20%. L’autoemotrasfusione non apporta invece benefici significativi agli atleti impegnati in discipline anaerobiche (sollevamento pesi, gare di salto e di sprint, lancio del peso ecc).
Inventata a Ferrara nella prima metà degli anni 80, l’autoemotrasfusione suscitò – addirittura tra medici sportivi – un coro di approvazione in nome della sua presunta “naturalità” salvo poi scoprire che questa tecnica (oltre a determinare una diminuita performance nei giorni successivi al prelievo) predisponeva alla formazione di coaguli di sangue dopo la reinoculazione con conseguente rischi di infarto, embolia, ictus. Altro rischio determinato dall’autoemotrasfusione, la compromissione degli organi di deposito (fegato, milza, pancreas e reni), già provati dall’intensa attività fisica, a seguito degli accumuli di ferro.
Come già detto, ad avallare la credenza della sostanziale innocuità di alcune tecniche di doping e quindi della loro liceità hanno contribuito anche alcuni medici i quali – tra l’altro – si sono prestati a tenere in osservazione i loro “pazienti” cercando di arginare i problemi che la sostanza dopante determinava. Si potrebbe aprire a tal riguardo un discorso davvero ampio sul rapporto che il medico deve avere con il suo “paziente”, ammesso che sia lecito considerare tale un atleta affetto dalla sola patologia di voler vincere a tutti i costi.
E questo necessiterebbe di una analisi davvero ampia, ma mi limiterò qui a qualche considerazioni.
La pratica del doping sta dilagando per la sfrenata commercializzazione che sta attualmente conoscendo lo sport, soprattutto a seguito della recente esplosione dei diritti televisivi associata ai grandi contratti di sponsorizzazione. Tale commercializzazione, con le lucrose poste in palio che ne derivano, ha portato ad una moltiplicazione delle competizioni sportive e alla riduzione dei tempi di recupero, il che provoca anche l’accorciamento della vita sportiva del professionista. A questo sono da aggiungere gli effetti perversi di contratti stipulati fra alcune associazioni sportive e i loro sponsor, che assegnano retribuzioni in funzione dei risultati ottenuti.
Già nel 1993 la “Commissione europea per il Piano di sostegno comunitario alla lotta contro il doping nello sport” aveva individuato nel medico una delle figure cardine per arginare questo fenomeno, allora agli esordi che si riduceva, sostanzialmente alla somministrazione di steroidi anabolico-androgeni; mentre e restava problematico allargare l’uso di questo termine anche a sostanze ergogene (ad esempio, la caffeina) comunemente utilizzate per migliorare le funzioni fisiologiche, psicologiche o biomeccaniche dell’atleta. Il mondo medico, d’altronde, già si era confrontato con questo problema. L’articolo 106 del Codice Deontologico del Medico del 1989, infatti, recitava: “Il medico non deve utilizzare trattamenti farmaceutici o di altra natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio fisico-psichico del soggetto. I trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati a migliorare le prestazioni degli atleti non possono essere tenuti segreti. Il medico di medicina dello sport è comunque tenuto a comunicare al medico curante i trattamenti cui intende sottoporre l’atleta”. Ancora più preciso l’articolo 107: “Il medico non può consigliare, prescrivere e comunque fare ricorso a trattamenti di Doping…” specificando la differenziazione tra: il doping come reato (frode) in sé e il doping come reato contro la salute . Nel Codice Deontologico approvato nel 1995 – e, sostanzialmente, su questi punti ancora in vigore oggi – il doping assume questione di estrema rilevanza specificando che “Il medico non deve utilizzare trattamenti farmacologici o di altra natura che possano influenzare artificialmente le prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. (….) Il medico non può consigliare o prescrivere trattamenti di doping. (…) Il medico dello sport è comunque tenuto a comunicare eventuali terapie al medico curante e deve segnalare all’Ordine professionale ogni prescrizione o suggerimento di assunzione effettuati da medici o da non medici, di farmaci, “integratori alimentari” o sostanze di cui ai primi due commi del presente articolo.(…) Qualsiasi consenso fornito dall’interessato non può mai esimere il medico dalle sue responsabilità, considerando che è in discussione la salute dell’individuo che, come è noto, non è un bene disponibile” .
In tema di doping confliggono i principi propri dell’etica medica: l’autonomia e la beneficenza/non maleficenza, il principio di giustizia e quello di integrità morale della professione.
Il primo principio, quello di autonomia, chiede che il medico rispetti le richieste dell’assistito formulate in modo libero e informato e che si alimenti e si promuovi l’autonomia decisionale della persona assistita . Esso potrebbe essere interpretato come la legittima volontà di uno sportivo di migliorare anche attraverso preparati farmaceutici la propria prestazione, consapevole dei rischi per la salute che ciò comporta perché edotto in merito dal medico. Ciò, quindi, deporrebbe a favore della moralità della prescrizione e assunzione di sostanze dopanti.
Il principio di beneficienza esige che il medico faccia il bene del proprio malato, rimuovendo il male che lo ha colpito e prevenendo future sofferenze. Il principio di non maleficenza chiede che il medico non arrechi danno al proprio assistito. Il medico è chiamato quindi a promuovere e salvaguardare la salute, intesa come bene essenziale per il suo assistito. In base a questo principio, il medico dovrebbe opporsi alla richiesta dello sportivo di somministrare sostanze che possano in un tempo più o meno lungo arrecare danno. Il principio di giustizia chiede che si valutino le ricadute, le conseguenze sociali (ossia gli effetti positivi o negativi su terzi) di una decisione clinica presa nell’interesse di un malato e che si ripartiscano equamente gli svantaggi, i benefici e gli oneri complessivi (attuali e futuri, immediati e a lunga scadenza) provenienti da un’azione inizialmente progettata e realizzata all’interno della diade medico-paziente. L’alterazione della regolarità delle gare sportive o il solo sospetto di gare truccate gettano un discredito su tutto il mondo sportivo, con conseguenze devastati sulla sua credibilità. Si allontanerebbero da esso non solo gli spettatori e gli appassionati, ma si rischia di promuovere una mentalità sportiva disposta a tutto per di ottenere dei risultati. Le conseguenze sociali dell’uso di sostanze dopanti mostrano l’illiceità morale della loro prescrizione e assunzione.
Il principio di integrità morale della professione chiede che sia rispettata l’autonomia del medico. Egli è chiamato a decidere secondo scienza e coscienza. Il medico non è quindi un mero esecutore delle richieste dei suoi assistiti, ma è chiamato ad assumersi la responsabilità morale dei suoi atti, anche in ordine alle possibili ripercussioni di essi nei confronti della professione medica. Il medico quindi dovrà rigettare l’uso di sostanze che esulano dalle finalità proprie della medicina -prevenire, diagnosticare, curare, riabilitare-, salvaguardando il senso proprio della professione.
Nel dirimere il conflitto tra questi principi, giova ricordare che vi sono beni che possiamo considerare non disponibili, anche se non assoluti. La vita si pone certamente tra questi. Va altresì ricordato che il medico non configura la sua prestazione unicamente come un atto tecnico, ma opera intrisa di valenza etiche imprescindibili.
La diffusione del doping travalica i confini degli sport professionistici. Il ricorso ad aiuti artificiali per aumentare le prestazioni fisiche si è diffuso in maniera capillare tra sportivi dilettanti, amatori, nelle palestre, persino nelle scuole. E persino tra i portatori di handicap.
Probabilmente, il caso più famoso in Italia è stato quello di Roberto La Barbera, uno dei più quotati e vincenti atleti disabili italiani, stella delle Paralimpiadi, trovato “non negativo” ai controlli antidoping. Un caso che appassionò anche il mondo scientifico per via del ritrovamento nelle sue urine di tracce davvero infinitesimali di stanozololo, uno steroide anabolizzante largamente diffuso negli sport di potenza perché aumenta la massa muscolare e la resistenza allo sforzo ma che è presente anche nello Stargate un diffuso farmaco ad uso veterinario che La Barbera somministrava nella pappa ai suoi nove cani, probabilmente contaminandosi le unghie che la Barbera usava rosicchiarsi. La controversa questione si trasformò in sospensione di appena due anni dalle competizioni scientifiche e oggi il “Barbaro” (come viene idolatrato questo campione del salto in lungo, con una gamba amputata) ritornato agli allori dello sport ha raccontato la sua storia nel romanzo della sua vita “Storia di un ragazzo in gamba”.
Meno fortuna hanno avuto i tanti atleti disabili trovati positivi al doping. Molti, a scorrere le liste pubblicate dall’International Wheelchair and Amputee Sport Federation e dal Comitato Italiano Paralimpico. Già uno studio pubblicato da un gruppo di studiosi dell’Universita di Trikala, in Grecia, rivelava che l’utilizzo di sostanze “a restrizione d’uso” e integratori durante la Paralimpiadi di Atene 2004 evidenziava che il 64 per cento degli atleti testati all’antidoping dichiarava di assumere integratori o farmaci ufficialmente a “restrizione d’uso” (in particolare analgesici e Beta-2 agonisti). Ancora più clamoroso quanto registrato dal Wheelchair and Amputee Sport Federation ai XIV Giochi paralimpici estivi di Londra del 2012 quando si scoprì che almeno dieci atleti che avevano perso la sensibilità degli arti inferiori si infliggevano traumi alle gambe per far salire la pressione e migliorare le prestazioni fino al 10 per cento.
Problematica è l’identificazione del doping in atleti disabili in quanto questo può mimetizzarsi nell’assunzione di farmaci, legata a terapie formalmente impiegate per il trattamento di una serie di patologie correlate ai principali quadri clinici peculiari della disabilità, come la vescica neurologica e le sue complicanze, la spasticità o le sindromi dolorose croniche. In questi atleti, infatti sono usati con maggiore frequenza i diuretici, per il trattamento dell’ipertensione e della vescica neurologica, i corticosteroidi, per la patologia asmatica e nella terapia di patologie acute a carico dell’apparato locomotore, i B-bloccanti per la cura del glaucoma e dell’ipertensione arteriosa, il B2-Agonisti per l’asma bronchiale, la morfina per le sindromi dolorose croniche altrimenti intrattabili e l’insulina in atleti affetti da diabete insulino-dipendente.
E’ opinione comune che lo sport sia nato nell’età antica, in Grecia, nella terra dei giochi di Olimpia. In realtà le differenze tra i giochi antichi e il moderno agonismo sono tali da escludere ogni possibile paragone: basti pensare al carattere sacro dei giochi greci, che si svolgevano nel- l’ambito di feste e cerimoniali religiosi. In realtà il moderno concetto di sport , secondo lo storico e sociologo tedesco Norbert Elias, è nato all’ombra delle grandi trasformazioni politiche dell’Inghilterra del XVIII secolo, quando, con l’avvento della dialettica parlamentare negli anni Venti, i contrasti cominciarono a perdere parte della loro ferocia. Allora finalmente la sconfitta politica non coincise più con la rovina personale, anzi essa dava nuovo slancio in vista della rivincita. Fu allora che le classi possidenti diedero vita alla «sportivizzazione» dei loro passatempi.
Nel 1751 fu fondata la prima istituzione sportiva, il Jockey Club, per regolare le corse dei cavalli. Gli antichi e spesso crudeli giochi dei nobili divennero nel giro di un secolo domestici e furono sottoposti a precise e universali regole che trovarono ispirazione nello spirito del fair play. Con l’espressione, oggi assai in voga, di fair play non si indicava semplicemente un gioco leale. Nell’ottica delle classi nobili britanniche essa stava a indicare il riconoscimento delle regole del gioco, spesso improntate alla durezza (i padri fondatori del calcio discussero a lungo prima di escludere la liceítà dei calci negli stínchi), e nello stesso tempo la capacità di dissimulare le sofferenze per le sconfitte subite e l’entusiasmo per le vittorie. Del resto l’educazione dei giovani gentiluomini dell’età vittoriana imponeva sacrifici e un’etica dell’autocontrollo indispensabili per affrontare gli spietatissimi conflitti dell’economia e per assolvere il compito di classe dirigente di un impero sterminato.
Questo è il concetto di sport che la nostra società ha ereditato e che, ancora oggi forgia lo sfrenato agonismo che sta dietro a pratiche eticamente scorrette come il doping.
Ma esiste un altro concetto di sport che è quello del gioco nel quale si sperimenta il confronto con l’altro e con i propri limiti, si apprende il rispetto delle regole ed il gusto dell’impegno. Sport come strumento di prevenzione, capace di richiamare l’attenzione delle persone, di aggregarle, di far acquisire una dimensione non alienante al loro tempo libero. Sport come attività che reca in sé una carica straordinaria e affascinante di umanità, di gratuità, di conquista, di coraggio, di pazienza, diventando avventura che riempie di segni, di obiettivi, di speranza. Sport come attività che reca in sé una carica straordinaria e affascinante di umanità, di gratuità, di conquista, di coraggio, di pazienza, diventando avventura che riempie di segni, di obiettivi, di speranza.
Giulio Tarro